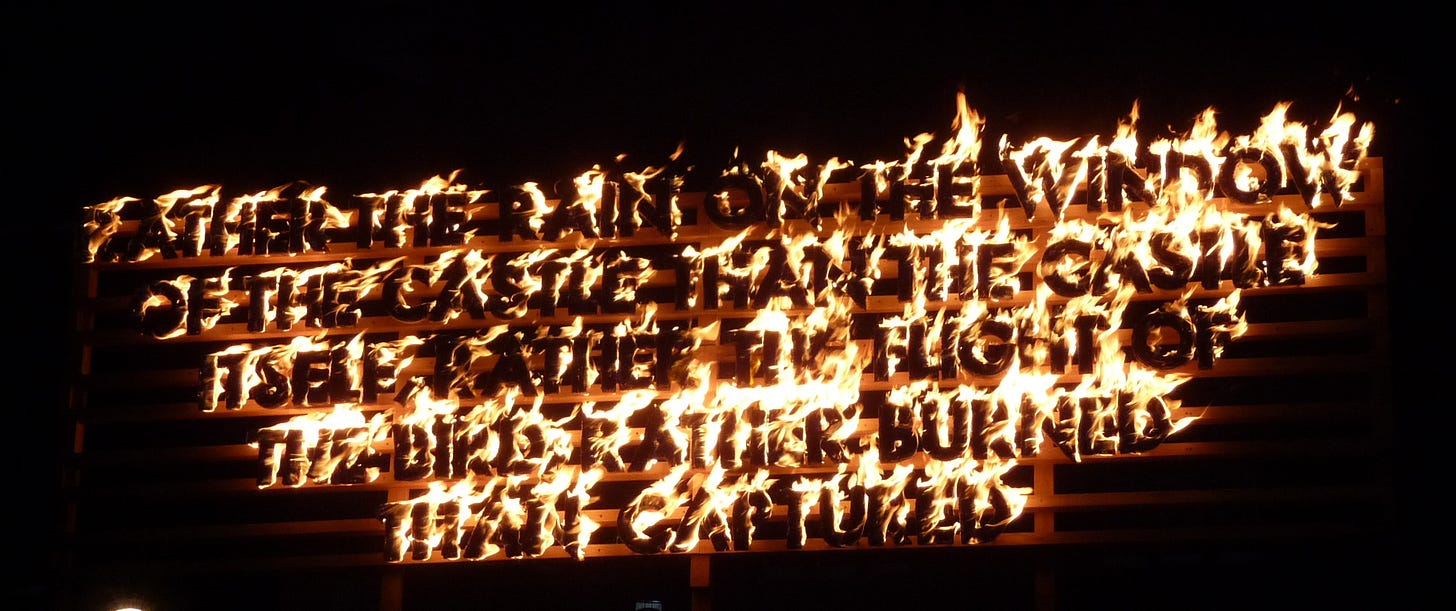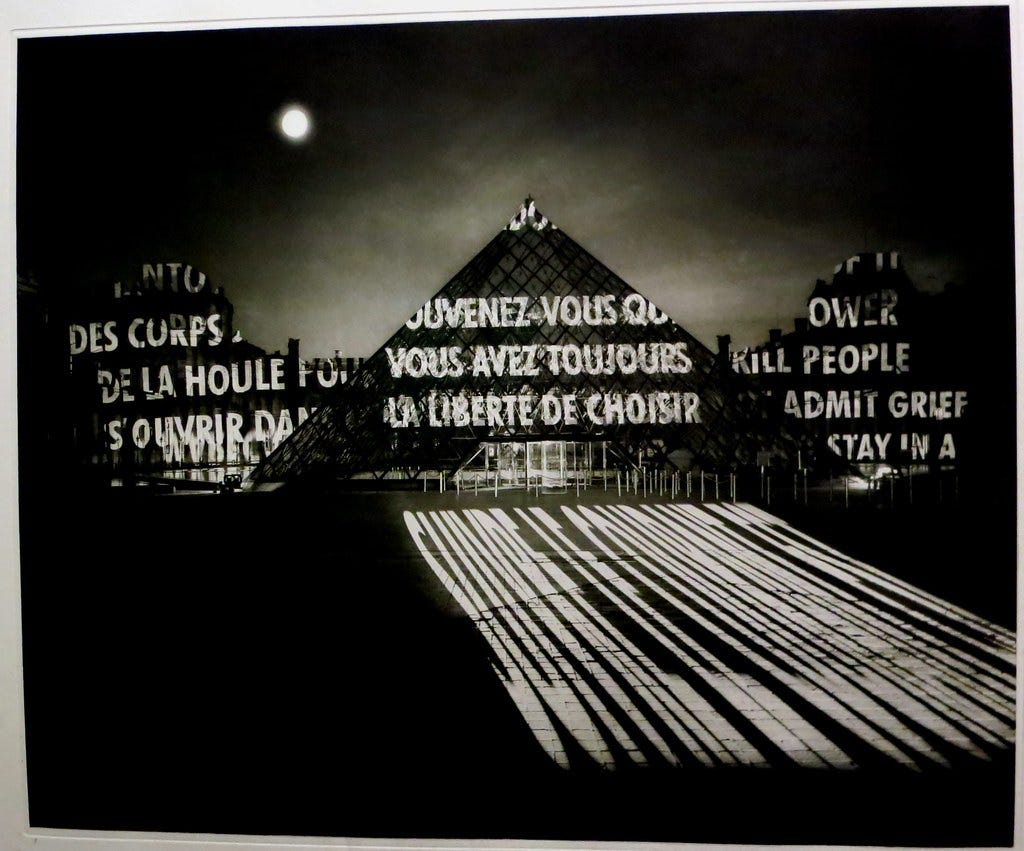Questa ovvia posizione di buonsenso – Gua Sha n. 50
Collezioni di intuizioni dispari
A un certo punto del testo scritto questa settimana da Sara troverete la parola “austerità”. È di questo che parla l’articolo, a partire da un saggio da poco pubblicato nella collana Einaudi Storia. È un libro che anch’io avevo intenzione di leggere e il testo di Sara, così attento a delucidare i trucchi e gli inganni nascosti dietro quella parola, mi ha ulteriormente incoraggiato a farlo. Vi dirò ora come risuona in me la parola “austerità” e a quali ricordi e momenti della mia vita si associa. È presto detto. Sono una partita IVA e come tale mi ritrovo spesso nella situazione di dover negoziare un compenso. Mi è capitato molte volte che con la scusa delle difficoltà, della delicatezza del momento storico, e quindi in sostanza dell’austerità – perché non ci sono soldi e bisogna stringere la cinghia, perché hanno tagliato questo e quello – il mio compenso negli anni sia rimasto bloccato e non sia mai cresciuto, perlomeno non in modo adeguato al costo della vita in generale o di una pizza in particolare, degli affitti, della luce elettrica o del biglietto della metropolitana. C’è però un fatto: è possibile, se non probabile, che effettivamente quel determinato datore di lavoro si sia trovato in un momento di difficoltà. Al momento di negoziare io ho sempre gettato la spugna, perché non fa parte del mio carattere discutere di denaro e mi viene più facile mettermi nei panni degli altri, cioè ragionare in termini sociali, che non individuali, quindi mi viene naturale provare a mettere sulla bilancia le mie esigenze con quelle del committente o di chicchessia. Mi sembra normale e perfino in via teorica funzionale, ancora prima che etico o morale. Credo pure che pensare che un datore di lavoro sia automaticamente un padrone delle ferriere è del resto una stronzata, specie nell’Italia di questi ultimi trent’anni, dove tanti piccoli imprenditori sono precipitati sul lastrico, perché strozzati dai debiti e dalle banche. Eppure, più volte ho avuto la sensazione che quella delle “difficoltà”, del “momentaccio”, e quindi dell’austerità, fosse solo una scusa, magari per dare meno a me e mettere qualcosa in più su un altro piatto, segreto, a me ignoto. Un velo di opacità è steso su ogni rapporto economico tra me medesimo fornitore e il committente. Dev’essere così che funziona anche su scala più grande. Di questo e altro si parla nel pezzo a seguire.
– Ivan Carozzi
Questa ovvia posizione di buonsenso
di Sara Marzullo
Le relazioni che finiscono con non sei tu, sono io, nonostante l’esplicita rassicurazione, lasciano il perenne dubbio che il problema sei proprio tu, soprattutto se il partner si premura di sollevarti da ogni responsabilità. Allo stesso modo, l’èra dell’informazione semplificata, che è l’èra dell’affermazione non sei tu, sono loro, non è capace di dissipare la sensazione che ci sia qualcosa di più, un tassello mancante che darebbe a quell’affresco di dati e cause-effetto maggiore senso, un’ombra che donerebbe profondità alla superficie integra e immacolata che ci viene presentata. La filantropia non è solo un escamotage per pagare meno tasse? Perché il nostro caporeparto vuole farsi tanto benvolere? Chi supportiamo quando supportiamo questa ovvia posizione di buonsenso? La cosiddetta realtà è un oggetto che forse non esiste neanche, ma ci viene presentato come la somma delle sue parti: come della Luna, anche qui vediamo solo la faccia illuminata.
I manuali di psicologia definiscono l’ansia come una paura senza oggetto perché slegata da un fatto o un evento determinato e, di conseguenza, impossibile da localizzare. Quando sono insonne, mi passano per la testa banali interazioni del giorno a cui non ho dato troppo peso: mi domando se questo voglia dire che le sottovaluto durante la veglia, o se è solo un modo per non pensare a ciò che veramente mi tiene sveglia, o se addirittura non ricorra all’ansia per non dormire e non incontrare me stessa, come un’ansia che ne copre un’altra più profonda. Quando a volte mi pare di cogliere l’oggetto, la fonte originaria delle mie angosce, quello che manca è il contesto dentro cui leggerla; mi trovo collezioni di intuizioni dispari, come un volto visto attraverso un vetro sporco, una parola cercata nel dizionario di un’altra lingua.
In queste settimane in cui ho cercato di capire cosa mi angustia – qualcosa che ha che fare con la paura di non farcela e la mia inadeguatezza nel campo del farcela – ho letto uno dei più interessanti libri di questo lungo anno, un saggio di storia economica la cui migliore virtù è insegnarci a guardare non il dito, ma la luna.
Il libro a cui mi riferisco è Operazione austerità. Come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo di Clara E. Mattei, uscito in Italia per Einaudi (in contemporanea con l’edizione americana). Nel libro Mattei fa una cosa semplice (si fa per dire) ma fondamentale: si chiede come è stata concepita la politica dell’austerità? Perché, nonostante le recessioni, la disoccupazione dilagante e la crescita sotto i livelli previsti, si continua a riproporre? È vero che, come scrive Mark Blyth, autore dell’altrettanto importante Austerity, l’applicazione – continua e reiterata – di politiche di austerità economica è una follia?
Come gentilmente spiega Don Draper ai clienti che vogliono demolire la Penn Station per costruire Madison Square Garden, “se non ti piace quello che viene detto, cambia conversazione”; come insegnano i veri saggi, se vuoi capire qualcosa del funzionamento del sistema in cui viviamo, non leggere il Guardian o Internazionale, ma i giornali di finanza, che non hanno nessun desiderio di indorare una pillola che tanto si papperanno quelli per cui quei giornali non sono scritti.
Clara E. Mattei, che non è né una stratega della pubblicità, né Lao Tze, ma parla con la stessa ferma autorevolezza, e nel suo libro ci spiega che se l’austerità non sembra funzionare, significa che stiamo guardando dalla parte sbagliata. Ci insegna non solo a ridirigere l’attenzione, per dare un contesto più adeguato alle informazioni folli, ma anche a comprendere che il fraintendimento alla base di come leggiamo lo stato della nostra economia è intenzionale – ci dice chi ha messo il ditino, insomma, e come abbia cambiato la conversazione.
In trecento pagine fitte di titoli di giornali, conferenze internazionali e dichiarazioni di tecnocrati, Mattei analizza con grande dettaglio le condizioni politiche, economiche e dei movimenti sociali, per rispondere alle quali, parallelamente in Inghilterra e in Italia, dopo la Grande Guerra e il biennio rosso, la classe dirigente inventò in campo il concetto di austerità finanziaria e si mise d’impegno perché venisse applicato, con le buone o le cattive.
Affinché il capitalismo ‘funzioni’ nel garantire crescita economica, il capitale inteso come rapporto sociale – la cessione cioè della forza lavoro in cambio di un salario – deve essere salvaguardato. In altre parole, la crescita economica presuppone l’esistenza di un preciso ordine sociopolitico, un ordine capitalistico. L’austerità, vista come impalcatura fiscale, monetaria e industriale di un’economia, tutela l’inviolabilità di questo ordine sociale.
Rimesso in contesto a cosa serve l’austerità – è insomma strumento di raffinata oppressione per salvaguardare lo status quo – i suoi successi diventano chiari; non stanno nella crescita economica e nella riduzione del debito pubblico, ma nel “facilitare una permanente e strutturale estrazione di risorse dai molti ai pochi”.
Per “spostare la ricchezza e le risorse nazionali verso le classi alte, le quali – insistevano gli esperti economici – erano le uniche in grado di risparmiare e investire”, il modo migliore è stato dividere i lavoratori e rendere obsolete le loro aspirazioni sindacali, depolicitizzare l’economia e trasformare questa in una scienza dura, fatta di numeri e calcoli, troppo complicata per essere capita, per cui è necessario affidarsi a specialisti, esperti, e a tecnici. Rinaturalizzare il capitalismo – che nella tecnocrazia è preso non come una risultante storica, ma un dato invariabile – fa sì che tutto ‘torni’, che l’appello al sacrificio individuale e l’obbedienza nei tempi difficili sia la corretta modalità di reazione:
Ciò che rende l’austerità, come insieme di politiche, così efficace è che è confezionata nel linguaggio di una teoria economica onesta e imparziale [...] In tal senso, l’austerità va compresa per ciò che è e che rimane: una reazione antidemocratica alle minacce di un cambiamento sociale spinto dal basso.
Ho aggiunto le virgolette a “torni”, perché se anche l’inganno sposta l’attenzione, l’imparzialità produce una quieta accettazione e le conseguenze dell’austerità fanno il resto, c’è qualcosa che sappiamo essere follia. Qualcosa non quadra in questa austerità da lacrime e sangue, perché la prospettiva con cui è disegnata è falsa e ingannevole e ce ne si accorge appena ci si sposta. Serviva leggermi questo saggio, che giustamente non contiene soluzioni o strategie per l’eversione, per capire quello che profondamente già sappiamo (o almeno sentiamo)? Lo stesso mi sono chiesta di fronte a Dominio di Marco D’Eramo, saggio sulla guerra ideologica condotta dagli imprenditori attraverso le fondazioni filantropiche, un manuale di egemonia di cui brother Pacifico ha scritto in maniera impeccabile su Il Tascabile (da quel pezzo ho preso la definizione di Lao Tze, “D’Eramo è un Lao Tze dello storytelling [...] Ha un modo raffinato di occupare il posto disponibile nel campo di battaglia, che sia lo Yin o lo Yang, il campo aperto o le spalle al muro”, kudos).
Questi libri ci dicono non tanto – o non solo – che questa è l’acqua, ma ci presentano il dettaglio di come il sangue è diventato acqua, per cui “da quarant’anni il neoliberismo si è affermato, ormai quasi incontrastato, come la religione civile che a livello globale governa l’economia, le società e la politica” (Michael Braun, Die Tageszeitung) o che “fra tante guerre, aperte e sotterranee, la più importante degli ultimi 50 anni è stata resa invisibile. È quella dei padroni contro i sudditi” (Daniele Barbieri, Left). Trovano l’origine dell’angoscia, che era stata camuffata, la riconnettono al giusto contesto. Come scrive Pacifico:
l’ideologia sa dare alla vita delle comunità il tipo di racconto capace di connettere i fatti della vita dandogli un senso. È la maniera più neutra di definire l’ideologia. Il mondo si cambia cambiandone il racconto. Lo fanno tutti, ma di solito chi è al centro di un sistema fa finta che la sua non sia ideologia, cioè racconto connettivo.
Non sto dicendo che invece di fare terapia dovremmo studiare economia, perché No era depresión era capitalismo; anche in quel caso mi pare che manchi qualcosa perché quella affermazione possa essere pienamente condivisibile. Del resto è depressione (un altro grande successo dell’austerità, va detto) ed è capitalismo. Leggere Operazione Austerità, come leggere Dominio, come leggere le dichiarazioni presunte o reali di Warren Buffett per cui “è in corso una guerra di classe, va bene, ma è la mia classe, la classe ricca, che sta muovendo guerra, e stiamo vincendo” è deprimente. Ma riconoscere l’intelligenza del nemico, la pervasività dell’ideologia dà una forma dell’ansia, che le permette di essere convertita in altro.
Nel suo saggio Melanconia di classe. Manifesto per la working class (Edizioni Atlantide, tr. Paola De Angelis), Cynthia Cruz affronta “la melanconia che nasce quando si abbandonano le proprie origini working class”. La separazione dalla classe di origine è per Cruz un lutto che non riesce a consumarsi (in questo, melanconia, appunto); l’atto necessario per entrare nel mondo del “progresso” dominato dalla borghesia, assume la forma di una ferita insanabile che provoca un lento sanguinamento. Vivere come transfugo di classe significa vivere nella nevrosi di non appartenere a nessuno dei due mondi, a cui si somma non solo la vergogna o il biasimo altrui per le proprie origini, ma anche la negazione stessa dell’esistenza di classi sociali. Cruz in quel bel saggio ne parla attraverso i lavori di artisti working class, le cui opere descrive come spettrali, infestate da una presenza fantasmatica, che lascia una patina opaca sopra ogni cosa.
Ma l’esperienza di alienazione non è propria solo di chi, da un retroterra proletario, ha fatto la cosiddetta carriera: anche chi non tradisce la propria classe di partenza è abitato da un inesprimibile e vischioso sentimento di dissociazione, di appartenenza a un mondo perduto a cui è impossibile ritornare. Dice Cruz che gli stati depressivi del padre, un venditore di auto usate che aveva trascorso tutta la propria esistenza living paycheck to paycheck (la definizione che trovo più chiara per cosa sia essere working class) sembravano derivare da una sconfitta di cui però non riusciva a prendere piena consapevolezza. Compito degli artisti e dei Lao Tze è mettere insieme un vocabolario che riesca a esprimere questa sensazione per gli altri; nel caso di lei, era stata la lettura di Mark Fisher a renderle visibile la violenza strutturale del sistema neoliberista a cui era soggetta, l’odio di classe che l’aveva fatta sentire fuori posto. Prima, esattamente come il padre, percepiva solo i sintomi della sconfitta, ma non riusciva a far mente locale su come e quando era avvenuta la guerra, chi la stava muovendo. Come scrive D’Eramo: “noi comunque ci portiamo dentro un’ideologia, che lo vogliamo o no [...] quando non aderisci volontariamente a un’ideologia (a una religione), vi aderisci involontariamente, ‘respiri’ ideologia”.
All’inizio, per questo pezzo volevo mettere insieme un quiz alla McSweeney's, chiedere ai lettori di decidere se una frase fosse stata scritta nel 1920 o nel 2008 o nel 2022, ma il gioco mi è sembrato così deprimente che ho lasciato stare (queste tre frasi sono dello stesso anno, “Una lotta costante, non per vivere, ma semplicemente per sopravvivere, è la punizione per essere poveri nell’èra dei profittatori”; “I rappresentanti degli Stati più deboli sono tornati a casa rafforzati nella convinzione che una finanza ortodossa non sia solo la politica giusta, ma l’unica possibile per i loro Paesi, se vogliono garantirsi la fiducia e l’assistenza degli altri”; “Accettare la necessità dell’austerità è dunque alla base di qualunque ripresa economica dell’Europa”, suppongo indovinerete facilissimamente).
Poi ho visto questo tweet e ho pensato: biennio rosso???